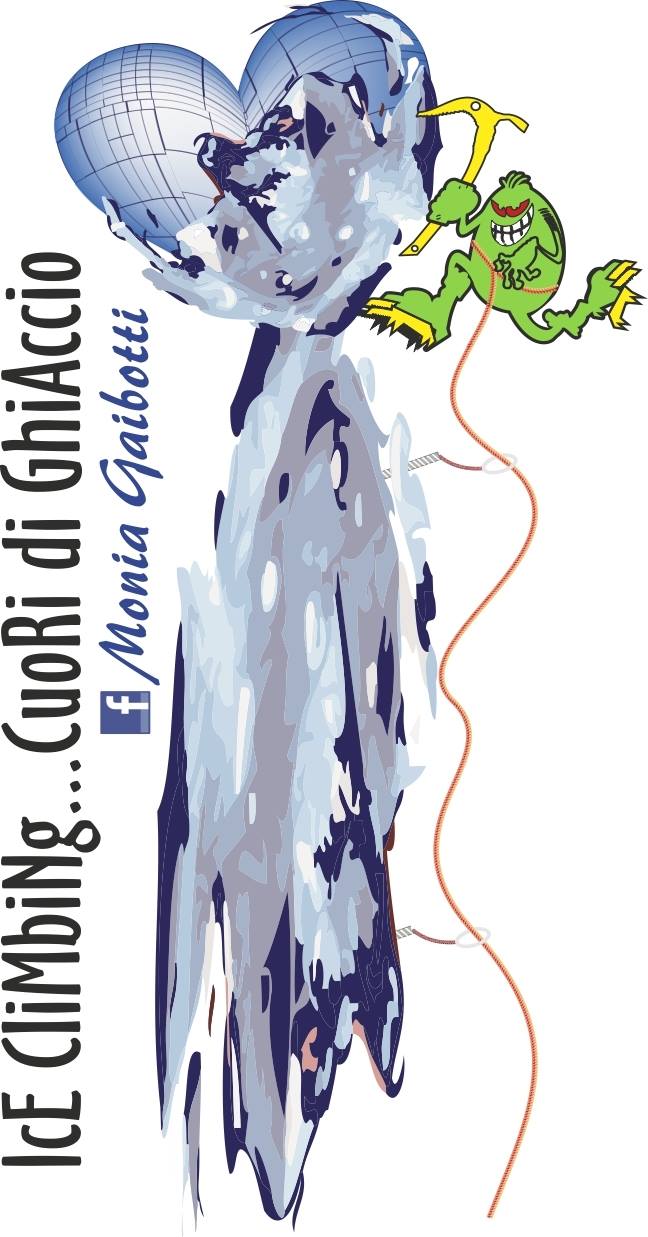Il “Compito” di Enrico è portare un gagliardetto sul cannone G149 sulle alti vette del nostro amato Adamello e immortalare l’immagine. Lui da buon Alpino sente il richiamo di questa grande impresa portata a termine da uomini che nella nostra patria credevano dando la loro vita per questo ed altro.
Mi chiede se posso accompagnarlo in questa avventura, accetto molto volentieri visto che è una zona che ho sempre voluto visitare per la sua importanza storica. Il racconto della nostra salita poco importa, lo scopo è stato raggiunto il sabato 15 settembre calcando nevi intonse e accompagnati da raggi di sole caldi e accoglienti. Il panorama è superlativo ed è tutto solo per noi, nessuno in giro fino all’attacco della cresta quando incrociamo i “primi” del sabato mattino….
Consiglio vivamente a chi non ha ancora potuto godere di questo viaggio di fare una visita sia al rifugio Ai Caduti dell’Adamello e poi godervi di questo spettacolare itinerario (Vetta Papa Giovanni Paolo II e per cresta al G149). Un ringraziamento doveroso a Romano il rifugista una persona splendida e che vi fa sentire a casa, Grazie!!
Grazie anche ad Enrico per la compagnia e Rocco e Claudio ora lascio spazio alla STORIA
CENNI STORICI
Il mattino del 9 febbraio 1916 il cannone parte da Temù trainato da cavalli sulle grosse, altissime ruote munite di cingoli; prima di sera raggiunge Malga Caldea (1584 m) dove termina la carrozzabile della Val d’Avio. La neve è alta e da là il pezzo potrà proseguire solo su slitte.
Viene smontato nelle varie componenti, tra le quali le maggiori sono la canna (oltre 33 quintali) l’affusto e le ruote. La canna e l’affusto vengono sistemati ciascuno su un robusto slittone in legno costruito appositamente, rinforzato da barre e lastre di ferro e il traino incomincia. Lo dirigono alcuni ufficiali ai cui ordini sono una sessantina di Artiglieri, tredici Genieri minatori, ai quali via via presteranno man forte duecento Alpini e Territoriali. Un nugolo d’uomini s’affaccenda e s’affatica intorno al mastodonte, che i soldati, argutamente subito battezzano “l’ippopotamo”. Un graduato precede, reggendo sulle spalle la doppia, grossa fune del traino e individua il punto preciso del percorso, già indicato di massima, in precedenza, dagli ufficiali e battuto sommariamente da uomini muniti di racchette. Alcuni metri dietro, due soldati, affiancati, sorreggono su una spalla una fune ciascuno, per evitare che sprofondi nella neve; segue il grosso della forza che, al grido “ohh …forza!” ripetuto ritmicamente tira a più non posso le grosse funi. Dietro lo slittone, sul quale è collocata l’enorme bocca da fuoco, uno e talvolta due soldati, mediante un robusto palo di ferro, impediscono al pezzo di retrocedere. La fatica è improba, perché si deve procedere lungo la linea di massima pendenza, non essendo pensabile affrontare il pendio a zig-zag, pena il rovesciamento dello slittone.
Nonostante una specie di pista sia stata battuta in precedenza, il carico spesso affonda e s’incaglia, resistendo tenacemente a tutti gli strattoni, anche i più forti. Tocca allora ai genieri intervenire per eliminare qui uno spuntone di roccia affiorante, là un tronco o una radice sporgente; oppure per mettere in opera – al fine di superare i punti più ripidi – speciali marchingegni di trazione, detti “capre”, argani con varie carrucole per demoltiplicare l’enorme sforzo della trazione.
Naturalmente il traino procede con una lentezza esasperante, oltretutto perché può avvenire soltanto di notte o quando le nuvole o la nebbia non consentono al nemico la ricognizione aerea.
Di giorno, quando l’atmosfera è limpida, il traino deve essere interrotto: sulle slitte vengono gettate palate di neve, mentre i soldati, muniti di lunghi rami di abete a mo’ di scope, hanno cura di cancellare minuziosamente le profonde tracce lasciate dallo slittone.
Occorrono una ventina di giorni per superare i quattrocento metri scarsi di dislivello tra la Malga Caldea e la Malga Laghetto, in quanto occorre risalire le tre cascate del torrente Avio, trasformate in ripidissimi canaloni ghiacciati.
Nella prima quindicina di marzo le cose dovrebbero mettersi al meglio, per quanto riguarda il terreno; il tratto tra la Malga Laghetto, la Malga di Mezzo e la Malga Lavedole infatti è quasi pianeggiante. Senonchè il tempo si è messo al peggio: per quasi due settimane nevica fitto ed imperversano bufera e tormenta. Il traino principale deve essere sospeso ma si provvede, anche a mezzo delle teleferiche, al trasporto di tutto il materiale accessorio.
Il pericolo delle valanghe è notevole, soprattutto in quel tratto così esposto, e in varie occasioni masse nevose seppelliscono il cannone, costringendo i soldati ad estenuanti fatiche per liberarlo dalla spessa coltre di neve. Le pessime condizioni climatiche impongono la sospensione di ogni attività dal 13 al 31 marzo.
Con il mese di aprile, il tempo finalmente migliora e il traino può essere ripreso.
La fatica si fa immane nel tratto denominato “Calvario”; gli uomini sono stanchi nel fisico e nel morale di quella monotona attività che dura ormai da troppo tempo. Nemmeno le distribuzioni periodiche di generi di conforto (vino, marsala, grappa e anice) servono a rinvigorire l’attività. Un bel giorno, però, un ufficiale ha un’intuizione folgorante.
Improvvisamente, la slitta con il barilotto del liquore compare un bel tratto più avanti del cannone anziché seguirlo a debita distanza e la distribuzione del “beveraggio” potrà avvenire solo quando il cannone avrà raggiunto il barilotto. Il cannone sembra aver messo le ali. A spronare inoltre gli addetti al traino, a moltiplicare le loro energie, a pungolare in quegli uomini il senso del dovere e della solidarietà militare è la vista dei feriti e dei caduti che scendono a valle, dopo le cruenti battaglie del 12 aprile. Consapevoli dell’importanza del loro contributo alla nuova battaglia che si annuncia prossima, stringono i denti e cominciano a tirare con tutte le
energie, tanto che il 17 aprile il cannone raggiunge il Rifugio Garibaldi (2535 m). Il dislivello di cinquecento metri da Malga Lavedole e il rifugio è stato superato in soli sei giorni.
I seicento metri che mancano per arrivare al Passo Venerocolo, al quale il cannone è destinato, vengono compiuti in dieci giorni così che, il 27 aprile 1916, il cannone, che ad onta delle previsioni pessimistiche in 78 giorni ha superato indenne millecinquecento metri di dislivello, giunge in postazione al passo (3236 m), appena in tempo per appoggiare con il suo fuoco il nuovo grande attacco.
Rimarrà oltre un anno sul Venerocolo, finché, nella sola notte del 6 giugno 1917, duecento Alpini ed Artiglieri, superando il Passo della Tredicesima e attraversando tutta la vedretta del Mandrone, lo trascineranno fin sulla selletta di Cresta Croce (3313 m), dove si trova tuttora.
DATI TECNICI
Il pezzo da 149 G (G sta per ghisa), era un cannone dell’artiglieria d’assedio, costruito per i tiri tesi. Il calibro era appunto di 149 mm. Era stato fuso nel 1896 dall’Arsenale di Torino. La canna lunga m 3,438 di ghisa, solcata da 36 rigature sinistrorse pesa, senza otturatore, 3216 chilogrammi; il pezzo in batteria, cioè pronto a sparare, 6.041 chilogrammi.
Poteva sparare i seguenti tipi di proiettili del peso variabile dai 30 ai 40 Kg: palla in acciaio, granata ordinaria in ghisa, shrapnell in ghisa, granata in ghisa acciaiosa, granata a liquidi speciali in ghisa, granata tipo H a liquidi speciali, granata monoblocco in acciaio, granata torpedine in acciaio, granata torpedine in acciaio a bocchino posteriore.
A seconda del tipo di proietto e della carica di lancio la gittata poteva variare da m 2.200 a m 9.300, ma sull’Adamello, grazie alla rarefazione dell’aria e all’alta quota, giunse a superare gli 11 chilometri. Durante le azioni di fuoco che richiedevano la massima celerità di tiro, furono raggiunti i due colpi al minuto.